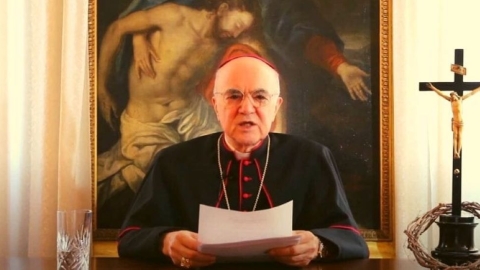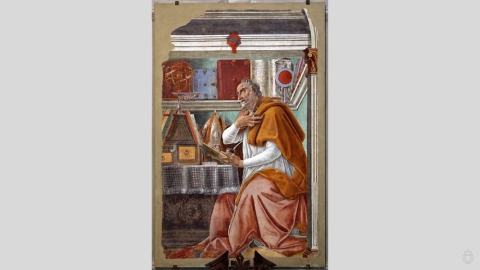La “morte cerebrale” ancora una volta sotto i riflettori

Mentre in Europa, e in Francia in particolare, infuria il dibattito sull'eutanasia, un recente studio d'oltre Atlantico rivela profonde riserve riguardo al criterio della morte cerebrale utilizzato per valutare la fine della vita di un paziente.
Fino alla metà del XX secolo, il medico constatava la morte – definita dalla filosofia cristiana, con tutti i dottori e i teologi, come la separazione dell’anima e del corpo – mediante l’osservazione dell’arresto cardio-respiratorio. A partire dagli anni ’50, sotto la pressione del progresso tecnico nella rianimazione e dell’interesse per i trapianti di organi, è emerso un altro approccio.
Nell'agosto del 1968, un collettivo chiamato Comitato Harvard, che riuniva medici, avvocati e teologi, pubblicò un documento fondamentale e propose di mantenere la nozione di morte cerebrale come segno di coma irreversibile, di per sé un criterio medico per la morte. Una prospettiva attraente per la medicina sperimentale, ma un terreno scivoloso per le scienze morali.
Poco più di due decenni dopo, Papa Giovanni Paolo II, dopo molte esitazioni, sostenne che "il criterio adottato per dichiarare con certezza la morte, cioè la cessazione completa e irreversibile di ogni attività cerebrale, se applicato rigorosamente, non sembra contraddire gli elementi essenziali di un'antropologia seria", in un discorso del 29 agosto 2000.
Giovanni Paolo II, visibilmente preoccupato, non è riuscito a esprimere un giudizio chiaro sulla questione e ha convocato in Vaticano almeno quattro riunioni straordinarie sull'argomento. Nel 2005, una riunione della Pontificia Accademia delle Scienze ha esaminato i concetti di morte cerebrale e trapianto e si è espressa contro la morte cerebrale. Inspiegabilmente gli Atti, pronti per la stampa, non furono pubblicati.
Nel 2006, sotto Benedetto XVI, si tenne con maggioranza favorevole un nuovo convegno, dallo stesso titolo "I segni della morte", che concluse il contrario; gli Atti furono pubblicati nel marzo 2007. Benedetto XVI, che sotto il suo predecessore era stato molto contrario a questo concetto, lo accettò, ma con riserve. Voleva un consenso scientifico sulla determinazione dell'ora della morte:
"È auspicabile quindi che i risultati ottengano il consenso dell’intera comunità scientifica per favorire la ricerca di soluzioni che diano certezza a tutti. In un ambito come questo non può esserci il minimo sospetto di arbitrarietà, e dove non c’è ancora la certezza deve prevalere il principio di precauzione", ha spiegato in un discorso del 7 novembre 2008.
Un "sospetto di arbitrarietà" sottolineato da una pubblicazione del Centro nazionale cattolico di bioetica (NCBC), datata 11 aprile 2024. Il NCBC constata "il fallimento dei recenti sforzi volti a risolvere la questione della determinazione della morte cerebrale", fallimento che ha portato al crollo dell’attuale consenso pubblico sulla morte e sulla donazione di organi, e che dovrebbe coinvolgere gli operatori sanitari cattolici a investire ulteriormente in questo campo e a dare il loro contributo alle questioni etiche in gioco.
"La principale causa di preoccupazione negli Stati Uniti oggi è che, sebbene la legge richieda la cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali affinché una persona possa essere dichiarata morta utilizzando criteri neurologici, il protocollo primario per diagnosticare la morte cerebrale non valuta chiaramente il funzionamento neuroendocrino nel cervello del paziente", scrive il presidente della NCBC Joseph Meaney, presentando numerose prove e fatti a sostegno.
"Se l’ipotalamo funziona ancora, allora sia legalmente che eticamente – da una prospettiva cattolica – quella persona non dovrebbe essere dichiarata cerebralmente morta. (…) Da qui la necessità di esami diagnostici più approfonditi per raggiungere la certezza morale della morte prima che venga autorizzato il trapianto di organi vitali", conclude Joseph Meaney.
Una certezza paradossalmente tanto più difficile da stabilire in quanto il progresso tecnico consente di mantenere in vita una persona in stato di "presunta morte cerebrale" per un periodo indefinito, a volte con liete sorprese in serbo. Più che mai, la cautela – soprannaturale – rimane essenziale in queste delicate questioni.
(Fonti: NCBC/Saint-Siège – FSSPX.Actualités)